Vincent Ward, Vigil, 1984, 90′.
Le immagini cinematografiche dei paesaggi neozelandesi passano fondamentalmente da due o tre progetti degli ultimi 25-30 anni: Il Signore degli Anelli/Lo Hobbit, Avatar e King Kong, con qualche suggestione proveniente da Lezioni di piano di Jane Campion. Nel primo, in particolare, Peter Jackson ha fatto di intere regioni un gigantesco set a cielo aperto, spesso con interventi quasi nulli in post-produzione – che bisogno aveva di intervenire su un paesaggio già di suo così “fantastico”? Bastava ruotare la sua cinepresa di 180° per passare dal totale di una gigantesca pianura dominata da monti innevati a un fitto bosco fangoso: ed ecco un nuovo set. I colori stessi di Wellington o Auckland (perché ogni parte del mondo ha i suoi colori) rimandano inevitabilmente a un luogo altro e fantastico, incontaminato e vivido. Nulla si addice meglio a questo fantasy cinematografico di derivazione americana.
Vigil (1984) di Vincent Ward è l’esordio al lungometraggio di un neozelandese uscito da una scuola d’arte che da lì a poco sarebbe diventato piuttosto conosciuto nel cinema mainstream occidentale. Il film è il primo lungometraggio della storia a concorrere per la palma d’oro al Festival di Cannes, ed è il primo di un percorso che sempre più si addentrerà nel circuito hollywoodiano: gli faranno seguito The Navigator: A Medieval Odyssey (anch’esso in concorso a Cannes nel 1988), Alien³ (diretto da David Fincher ma su una storia di Ward) e il ben più conosciuto Al di là dei sogni con Robin Williams.
Ciò per dire che le immagini iper-colorate e iper-pittoriche di film come Al di là dei sogni (1998) o di Amabili Resti del già citato Jackson (2009) sono frutto di un certo background culturale (Ward è anche pittore e videoartista), di un certo background inteso come sfondo (vivere in posti così “visivi” dev’essere a tratti snervante), e di una tendenza esteticamente ipertrofica tipica da un lato degli anni ’80 e dall’altra del cinema commerciale contemporaneo. Non che qui si voglia fare un discorso determinista attorno al gesto artistico, quanto usare questo breve excursus per avviare una riflessione su questo esordio così impattante e anomalo (perché non ce ne facciamo nulla dell’ipertrofia senza equilibrio).



Il film racconta una vicenda che ha sapore di mito greco: in una fattoria in uno sperduto paesino rurale l’undicenne Toss vive con i suoi genitori e suo nonno. Un tragico evento scuote la sua psiche: la ragazzina assiste alla morte del padre e contemporaneamente alla comparsa di Ethan, un misterioso uomo che ne recupera il cadavere e lo riporta alla vedova. La crescente presenza di quest’ultimo nella vita della famiglia turba fortemente Toss, la quale inizia a percepire Ethan come una vera e propria minaccia al limite del sovrannaturale, quasi fosse una sorta di angelo della morte scagliatosi sul loro piccolo mondo.
Vincent Ward fa appello, inquadratura dopo inquadratura, suono dopo suono, sguardo dopo sguardo, a tutto quel background di cui s’è detto per evitare didascalie letterarie o artifici teatrali. Appiattisce ogni profondità, ingigantisce il mondo a (s)favore dello sguardo di lei, si fa poetico nello sguardo, dove per poetico si intende l’assunzione del film della cognizione turbata del mondo di Toss. E così, dunque, inquadrando un mondo dal basso, in controluce, iconizzando ogni figura e facendone un totem, un terrore intimo diventa terrore del film intero – d’altra parte quant’è facile, figurativamente, per la macchina da presa assecondare il dubbio di Toss che chiede «Siamo tra le nuvole ora?» in cima a un monte avvolto dalla nebbia? Come se questo non bastasse, il cervello del film genera suoni anomali, musiche elettroniche o liriche, crea sfasamenti percettivi rispetto all’epoca e alla condizione in cui dovrebbe trovarsi questa famiglia. E quando una triste melodia di pianoforte rischierebbe di enfatizzare inutilmente una scena drammatica, ecco che si opta per la soluzione opposta: l’audio sparisce, resta il respiro di lei. E se il solo respiro dovesse causare una simile, facile suggestione, Ward ricorre a una soluzione che solo l’anno dopo sarebbe stata utilizzata al vertice massimo dell’espressività cinematografica in Va’ e vedi di Ėlem Klimov: suoni stridenti e astratti che si spengono nel volto di Toss che porta le mani alla testa come Aleksej nel film del 1985.








La mente di Toss si scinde quando assiste a una sovrapposizione devastante: la morte di suo padre coincide con uno sparo, e lo sparo coincide con la comparsa di Ethan. La morte dell’uno si compenetra con l’arrivo dell’altro. E l’arrivo dell’altro forza un ulteriore incrocio: il suo avvicinarsi alla madre della ragazza risveglia nella prima una seconda giovinezza, nell’altra la pubertà. E la pubertà porta con sé il sangue. Quel sangue che Toss sente dentro di sé e che arriva anche dal di fuori. Quello derivante dalla pratica del taglio delle code delle pecore, durante la quale Ethan lo fa schizzare inavvertitamente sul volto della ragazzina. Questa torna a casa e trova sua madre, in una stanza (e un ambiente) astrattamente chiara e illuminata intenta a mettersi il rossetto sulle labbra. È lo stesso colore, e lei è così bella. Perché lei sì e io no? Ed ecco che Toss si spalma sul viso quegli schizzi di sangue, nel tentativo ingenuo di mimare quella figura adulta con la quale contendersi il nuovo compagno/papà.
Di questa contesa è al corrente anche la madre, che si inserisce nell’ennesimo punto di passaggio della vita di Toss (che in realtà si chiama Lisa – ma questo lo si scopre solo a film inoltrato, e non è forse un caso, dal momento che pare proprio non si voglia esporre in maniera palese il sesso di questa ragazzina, androgina come molte/i fanciulle/i di quell’età). In un isolato momento di profonda intesa tra la ragazza e Ethan, in cui egli assume incidentalmente e onestamente un ruolo paterno, Toss sembra riuscire ad accettare la morte del padre, o quantomeno a realizzarla, e quindi ad avviare il primo fondamentale passo per metabolizzarla. Ecco, questo passaggio è rotto dall’intervento della madre che caccia via Ethan dalla fattoria. Perché lo fa? Quella sera Toss, rientrando con lei, le racconta dell’uomo e della loro chiacchierata. Dice alla madre che l’uomo sa di cervi, di falchi, che è capace di catturare gli spiriti nel vetro. Le dice anche: «Gli ho succhiato il dito».




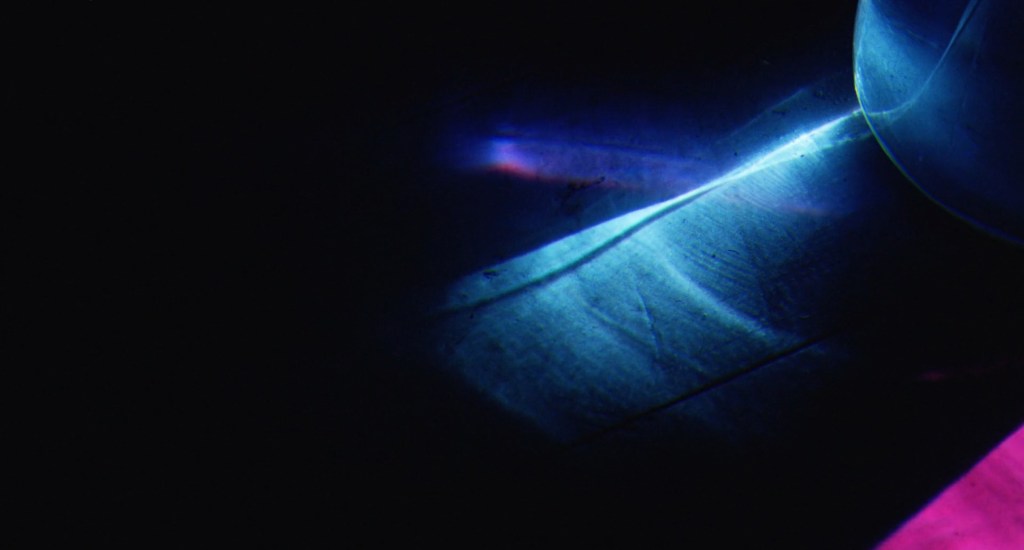

C’è un intero mondo, in sostanza, che Toss sta scoprendo e che non le si da immediatamente allo sguardo. Un mondo fuori dal suo, un mondo che non ha solo i colori verde acceso e azzurro incandescente dei suoi monti e dei suoi cieli. C’è il nero, il rosso, il grigiume putrido delle paludi e il bianco sporco delle pecore. C’è soprattutto qualcosa al di fuori e al di là, dentro agli altri e fuori dalla fattoria. È per questo che Ethan è una figura sproporzionata, ma soprattutto è per questo che gli occhi di Toss/Lisa guardano spessissimo fuori dall’inquadratura (verso un fuoricampo che il regista decide di non concedere mai allo spettatore), è per questo che i pochi dialoghi dei personaggi ruotano attorno al volare, ai falchi, ai pappagalli (siano questi gli attrezzi del meccanico o gli uccelli); è per questo, infine, che i personaggi sono sempre sull’uscio di casa, della stalla, del capannone, sempre di soglia in soglia. Sempre verso il fuori, sempre verso l’alto, sempre tutto troppo grande, – crescere, in sostanza.
E tu, tu pure –
Paul Celan, Di soglia in soglia
fatta crisalide,
come tutto quello
che la notte ha cullato.
Questo sfarfallio, questo volteggiare intorno:
io lo sento – e non lo vedo!
E tu,
come tutto quello
che è sottratto al giorno:
crisalide.
E occhi, che ti cercano.
Tra questi il mio.
Uno sguardo:
un altro filo, che ti avviluppa.
Questa tarda, tarda luce.
Io so: i fili luccicano.
Cosa succede quando questa prospettiva infantile assunta dalla cinepresa, questa soggettiva libera indiretta che Pasolini identificava come base del Cinema di poesia, si ipertrofizza? E al cromatismo spinto di queste meraviglie neozelandesi private della loro prospettiva? Al discorso attorno alle soglie, al suono, al fuori campo, ai rapporti sottesi di un film che in principio si sarebbe dovuto chiamare First Blood, Last Rites (poi fortunatamente trasformato in Vigil). Cosa accade alla delicatezza, alla timidezza, alla levità o alla gravità quando si ipertrofizzano? Diventano spettacolo, sovraesposizione del visibile (pornografia), pittura, letteratura, teatro, menzogna, cinema commerciale americano. In tutto questo Vigil sembra proprio stare sulla soglia.


Lascia un commento